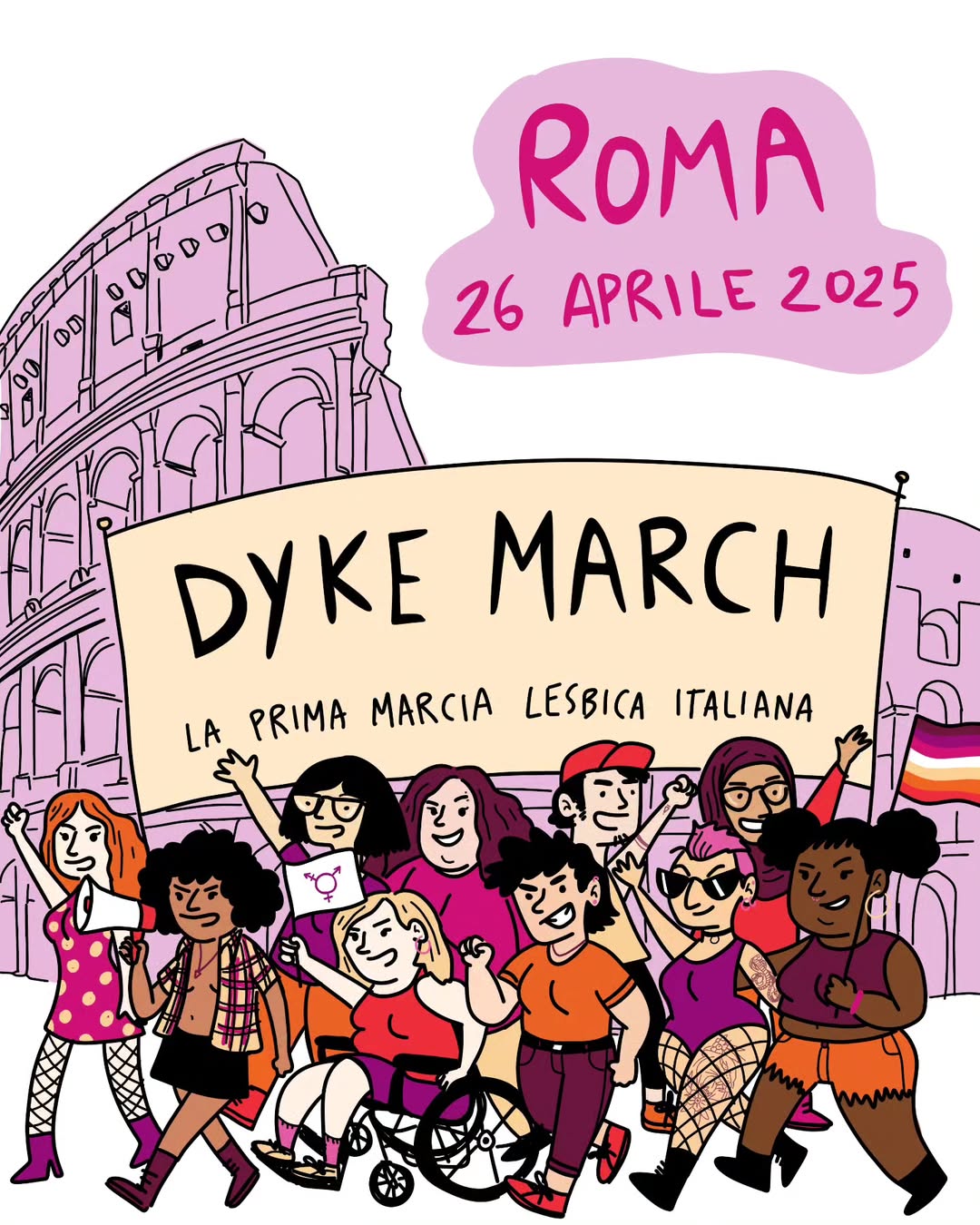Adozioni da parte di single, Celentano: “Si è aperto un varco, ora la genitorialità sia democratica, inclusiva e libera”
“Finalmente si può sperare in un futuro migliore. Adozioni da parte di coppie omosessuali? Periodo storico non facile, ma sono ottimista”

La Consulta con una sentenza storica apre all’adozione di minori stranieri in situazione di abbandono da parte di single. Un provvedimento innovativo che mette in luce il principio di autodeterminazione, non relegando la genitorialità a un mero desiderio e aprendo le porte a una società più democratica e inclusiva. Per capire come funziona il sistema di adozioni ne abbiamo parlato con Stefano Celentano, consigliere della Corte d’Appello di Napoli, da anni impegnato sul tema dei diritti delle persone e delle famiglie.
L’Italia dal punto di vista legislativo è regolamentata dalla legge n.184 del 1983 per quanto riguarda le adozioni nazionali e internazionali. Un provvedimento in vigore da 42 anni, non rischia di essere datato?
La norma non è stata modificata. Sebbene la giurisprudenza in alcune ipotesi – come nel caso della stepchild adoption – abbia allargato le maglie del novero degli adulti come potenziali genitori adottanti, l’impianto normativo è rimasto più o meno stabile. Questo aspetto evidenzia il dato anacronistico rispetto ai mutamenti sociali e alle idee, alle visioni e alle prospettive che oggi abbiamo delle dinamiche familiari e relazionali.
Cosa è cambiato?
Basta considerare ad esempio l’aumento dei minori in stato di adottabilità. I bambini stranieri, soli e in condizioni di estrema fragilità, negli anni Ottanta non erano così tanti. L’incremento è stato determinato dall’inasprimento delle guerre e dei conflitti o dalle difficoltà economiche del Paese di origine, tutti temi tristemente oggetto di cronaca quotidiana. E poi c’è la questione della legge n.76/2016 sulle Unioni civili che ha modificato lo scenario italiano, offrendo la prospettiva necessaria della eterogeneità dei nuclei familiari riconosciuti dall’ordinamento, a cui va attribuita la piena dignità di essere considerati famiglie a tutti gli effetti.

Stefano Celentano
Da qualche settimana anche i single possono adottare i minori stranieri. Si tratta di una sentenza storica della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1?
La Consulta interviene soltanto in senso interpretativo o demolitivo delle norme. L’organo di garanzia costituzionale, su ricorso dell’autorità giudiziaria che si stava occupando del caso di una donna di cinquant’anni – non coniugata e desiderosa di adottare un bambino residente all’estero – ha sancito che il divieto di tale forma di adozione per le persone di stato libero non è in linea con alcuni dei più importanti principi della Costituzione, e ha così dichiarato l’illegittimità della norma in esame. Con questa pronuncia di portata innovativa si è stabilito che anche un individuo non coniugato possa adottare sulla base di due principi fondamentali: il rispetto del desiderio di costruirsi una famiglia e la libertà di autodeterminazione dell’adulto. Quando si parla del complesso mondo della genitorialità, la prospettiva diviene ben più ampia del solo interesse del minore – che come sempre è il focus principale ed è giusto che sia così – perché il giudice delle leggi ha affermato, in modo chiaro, che anche la posizione dell’adulto che intenda divenire genitore debba essere osservata, salvaguardata e tutelata. La genitorialità non può essere limitata all’espressione di mero desiderio, perché, ci dice la Corte, è una situazione giuridicamente attiva e connessa al legittimo dinamismo della libertà di autodeterminazione dell’adulto, che può spingersi anche sino al riconoscimento giuridico del suo interesse a divenire genitore.
I single non possono adottare i minori nati in Italia…
La Corte costituzionale nel sistema dell’architettura democratica delle varie giurisdizioni, è il giudice delle leggi che si esprime su sollecitazione dell’autorità giudiziaria ordinaria per valutare se una norma è in linea con i principi della Costituzione. C’è ancora un’esclusione del regime dell’adozione nazionale, che non è dovuta a particolari eccezioni o a questioni di merito. Non c’è una discriminante in questo senso. La Consulta ha risposto alla questione di una donna che stava tentando di adottare un bambino residente all’estero. Se questa stessa richiesta fosse stata relativa a un caso di adozione su suolo nazionale, probabilmente saremmo arrivati allo stesso risultato perché l’argomentazione che ha elaborato la Corte è universale e basata su principi di diritto trasversalmente validi.

La Cassazione si è espressa favorevolmente ai documenti con “genitore e genitore”, dicendo stop alla dicitura “padre madre”…
In realtà era anomalo il contrario. Nel 2019, il ministero dell’Interno aveva proposto di modificare la vecchia norma con una circolare ministeriale, eliminando la dicitura precedente – risalente al 1931 – che prevedeva l’iscrizione “genitore o di chi ne fa le veci” per sostituirla con “padre” e “madre”. Per chi ha buona memoria, la vecchia dicitura era quella che da studenti trovavamo scritta sul libretto delle assenze a scuola, prima del registro elettronico. Sei anni fa si è tentato questo colpo di mano sostituendola con i termini “padre” e “madre”. La Cassazione ha giustamente stabilito che la dicitura non rispetta tutte quelle famiglie in cui i genitori sono persone dello stesso sesso. La disposizione del 2019 offriva un paradigma obbligato e soprattutto imponeva a uno dei due genitori, in questi casi, di “intestarsi” un sesso biologico che non gli apparteneva, diverso rispetto alla sua identità, con un enorme pregiudizio alla sua persona. La Cassazione ha confermato il principio sancito dalla Corte di Appello di Roma, sottolineando che l’indicazione “padre e madre” è assolutamente discriminatoria perché non tiene conto delle famiglie in cui i minori crescono in ambienti omogenitoriali, e in cui tutti i protagonisti, adulti e minori, hanno pieno diritto a vedersi riconosciuta nei documenti pubblici l’esatta e concreta realtà quotidiana che vivono, senza finzioni o imposizioni immotivate. Dopo quasi un secolo si ritorna alla precedente dicitura generica, che in maniera intelligente non si occupa del sesso del genitore, ma indica le persone che si prendono cura del minore e ne hanno la responsabilità e la rappresentanza.
La legge n.184 non rischia di creare una distinzione tra genitori di serie A e serie B?
Oggi il numero delle coppie non sposate è in crescita. Una legge del 2012 stabilisce in assoluto la parità di diritti tra figli nati all’interno di un matrimonio, figli cosiddetti non matrimoniali (nati da coppie di fatto), e figli adottivi. A questo status unitario di figlio, io penso che corrisponda uno status unitario di genitore. Così come lo sono i figli, anche i genitori devono essere tutti uguali: hanno tutti gli stessi doveri e diritti all’interno delle dinamiche familiari. Per cui occorre impegnarsi in modo che questo principio di logica sociale divenga sempre più calato nella realtà.
Prossimo passo l’adozione da parte di coppie omosessuali. Prospettiva vicina o lontana?
Sono un ottimista di natura, anche se in questo periodo storico non è facile ipotizzare accelerazioni in questo senso. Il riconoscimento dei diritti a volte sembra diventare un’utopia e la politica è spesso lontana dalle istanze e dalle dinamiche sociali. Da una parte il matrimonio non è più un sintomo di solidità come in passato, e quindi l’esclusione dall’adozione per le coppie non sposate si basa su un presupposto non più reale, perché non è certo che con il matrimonio si garantisca una prognosi di stabilità alla vita del minore adottato. Sulla legge delle Unioni civili c’è invece un chiaro paletto rispetto alla disciplina delle adozioni, una clausola che ne impedisce l’applicabilità fatte salve allo stato le ipotesi riconosciute dalla giurisprudenza nella forma della stepchild adoption a partire dal 2016. Però proprio su questo aspetto, e nel disciplinare la forma speciale di adozione, la Cassazione ci ha detto in modo chiaro che l’orientamento sessuale di un adulto è un dato di fatto irrilevante rispetto alla capacità di essere genitori e alla sua idoneità a diventarlo, in astratto e in concreto. Se uniamo questa affermazione al principio della libertà di autodeterminazione orientata anche all’ambito genitoriale, richiamato oggi dalla Corte costituzionale, si apre effettivamente un nuovo e potente varco di ragionamento in diritto rispetto a tutte le forme di famiglie e a tutti i progetti condivisi di genitorialità, per i quali io ho sempre ritenuto che non esistano specifici ostacoli, e ciò anche per la mia lunga esperienza di giudice della famiglia.
C’è speranza…
La pronuncia della Corte costituzionale sull’adozione internazionale da parte di persone di stato libero mi fa sperare in un futuro migliore, e credo che si sia aperta una breccia. La pronuncia della Consulta si esprime con un linguaggio moderno e colto: questo divieto non è coerente con i principi di una società democratica. Il riconoscimento della libertà di autodeterminazione, espressa in tutti gli orizzonti della genitorialità, è un argomento dirompente. Un passaggio rivoluzionario, forse la Consulta ci ha voluto dire che è arrivato il momento di ipotizzare una genitorialità più inclusiva e libera. Forse la Corte ci indica una direzione, e a me piace pensare sia così.